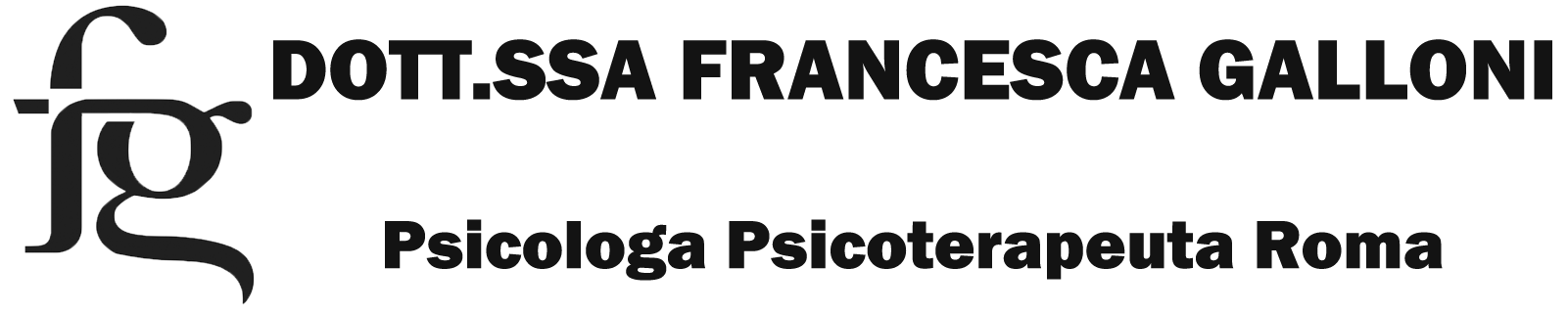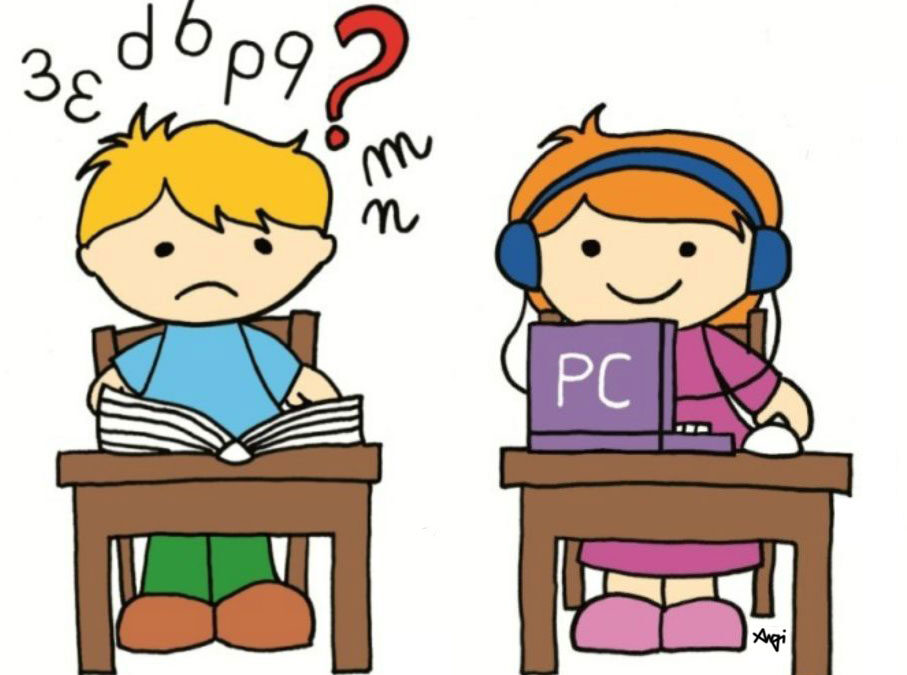DSA: NON SI VEDE MA QUANDO C’E’ COSA SUCCEDE?
Parlare di DSA oggi a 12 anni dall’uscita della legge 170 sembra quasi anacronistico, eppure i nostri figli con DSA non sempre hanno una vita facile. Vediamo assieme come fare per includerli in un sistema scolastico sempre più performante e non sempre inclusivo e formato. In Italia si stima che il 3-5% della popolazione in età scolare presenti un DSA, ma sono molti i casi in cui i DSA non sono riconosciuti, con pesanti conseguenze nella carriera scolastica e lavorative, oltre che sul piano emotivo e sociale.
Che cosa significa DSA?
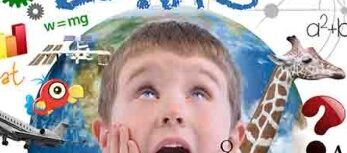
DSA è l’acronimo di DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO e si riferisce a un gruppo di disturbi specifici dell’apprendimento scolastico relativi all’acquisizione e all’uso di abilità di lettura, scrittura e matematica. I DSA sono disturbi evolutivi, per cui le abilità di lettura scrittura e calcolo tendono a migliorare, anche se il disturbo permane e si evidenzia in modo critico soprattutto nel periodo scolastico.
Differenza tra difficoltà di apprendimento e disturbi dell’apprendimento
Quando parliamo di difficoltà d’apprendimento intendiamo situazioni generiche e non specifiche che ogni studente può incontro nel corso della sua carriera scolastica. Diverse possono essere le cause: scarsa applicazione nello studio, insegnamento inappropriato o svantaggi socio-culturali. Queste difficoltà sono modificabili.
Al contrario, i disturbi dell’apprendimento sono dovuti a un deficit neuropsicologico relativo ai meccanismi deputati all’apprendimento. Questi disturbi hanno carattere di cronicità e sono specifici in quanto riguardano un’abilità circoscritta, mentre il funzionamento intellettivo è preservato: questo significa che si rileva una forte discrepanza tra il il funzionamento cognitivo che è nella norma e un’abilità specifica ( vedi lettura, scrittura o calcolo) che invece risulta essere deficitaria rispetto all’età cronologica e alla classe frequentata dal soggetto.
Comorbilità?
I disturbi specifici d’apprendimento che riguardano le abilità di lettura (dislessia), di scrittura (disortografia e disgrafia) e di calcolo (discalculia) risultano a volte associati: possiamo rilevare la dislessia associata alla disortografia, alla disgrafia, alla discalculia a ad altri disturbi evolutivi, come ad esempio il disturbo da deficit di attenzione-iperattività o disturbi del comportamento.
Quando si giunge alla diagnosi di DSA?
Quando ci accorgiamo che nelle prime fasi dell’apprendimento scolastico ( le prime classi della scuola primaria) il nostro bambino fa fatica a decodificare i suoni, la sua lettura è lenta e stentata, tende a restare sillabata ed è caratterizzata da una serie di errori, così come la scrittura è caratterizzata da una grafia quasi illeggibile e da errori di tipo fonologico e non fonologico, allora è arrivato il momento di intervenire per fare chiarezza! È importante quindi l’individuazione precoce del disturbo.
La diagnosi di Dislessia e Disortografia/Disgrafia si fa verso la fine della seconda elementare. Per la diagnosi di Discalculia è necessario aspettare la fine della terza elementare.
Vediamo inoltre quali possono essere i principali fattori di rischio: i principali fattori di rischio di cui è stata dimostrata o ipotizzata l’associazione con lo sviluppo di DSA (Consensus Conference, 2011) sono la presenza di un disturbo di linguaggio, la familiarità per DSA (40%), basso peso alla nascita e/o prematurità.
Come muoversi per attivare l’iter burocratico?
E chi ha il compito di effettuare la diagnosi di DSA?
La diagnosi di DSA solitamente è eseguita da:
-Equipe multiprofessionale costituita come unità minima da: Neuropsichiatra Infantile, Psicologo e Logopedista che deve essere presente in ogni USL.
-Strutture sanitarie private, accreditate ai sensi della L.R. 51/09 per le discipline di neuropsichiatria infantile e psicologia in regime ambulatoriale, al cui interno opera la figura professionale del logopedista. Le suddette figure professionali devono avere comprovata esperienza clinica nell’ambito delle diagnosi di DSAp;
-Centri ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale privati, accreditati ai sensi della L.R. 51/09, al cui interno operano le figure professionali del neuropsichiatra infantile, psicologo e logopedista con comprovata esperienza clinica nell’ambito delle diagnosi di DSA.
La certificazione diagnostica è finalizzata all’attivazione da parte della scuola di una didattica personalizzata ed individualizzata, alla predisposizione degli strumenti compensativi e all’adozione delle misure dispensative e delle specifiche modalità di valutazione di cui alla Legge 170/2010 e alle “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA di cui al Decreto del Miur n.5669 del 12 luglio 201.
Il protocollo diagnostico prevede:
a) visita specialistica
b) valutazione clinica multidisciplinare – valutazione intellettiva cognitiva – valutazione abilità di lettura e scrittura ed eventualmente delle funzioni linguistiche orali – valutazione abilità logico-matematiche ed eventualmente delle funzioni cognitive non verbali – valutazione psicopatologica e neurologica
c) altre: in relazione alle difficoltà emerse dall’osservazione clinica del bambino potranno essere previsti altri esami di approfondimento clinico, esami strumentali, visite specialistiche
d) discussione del caso in équipe e redazione della certificazione
e) colloquio con i genitori e consegna della certificazione
Sarà cura della famiglia comunicare l’esito della valutazione diagnostica al pediatra inviante, il quale, per i pazienti diagnosticati, potrà fare riferimento all’équipe che ha effettuato il percorso diagnostico. La certificazione su richiesta della famiglia, è trasmessa, ove possibile, per via telematica alla scuola, nel rispetto della normativa sulla privacy. È sempre a cura della famiglia il compito di consegnare la certificazione al Pediatra e alla Segreteria del Dirigente scolastico per l’attivazione dell’intervento specifico. Dopo essersi accertata che la documentazione sia stata prodotta in conformità a quanto previsto dalle linee guida la scuola ha determinati compiti da assolvere:
1. presa in carica dell’alunno da parte dell’intero consiglio di classe o team docente;
2. coinvolgimento della famiglia;
3. redazione del PDP (Piano didattico personalizzato) entro il primo trimestre scolastico.
4. La stesura del PDP è di competenza dei docenti e non richiede la partecipazione vincolante e la sottoscrizione (come avviene invece per il Progetto Educativo Individualizzato PEI) di operatori sociosanitari.
Cosa deve contenere il PDP?
Il PDP deve contenere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo), attività didattiche personalizzate (per ciascuna disciplina interessata), strumenti compensativi, misure dispensative, patto con la famiglia, forme di verifica e valutazione personalizzate.
*per maggiori informazioni o una consulenza scrivere a info@francescagalloni.it